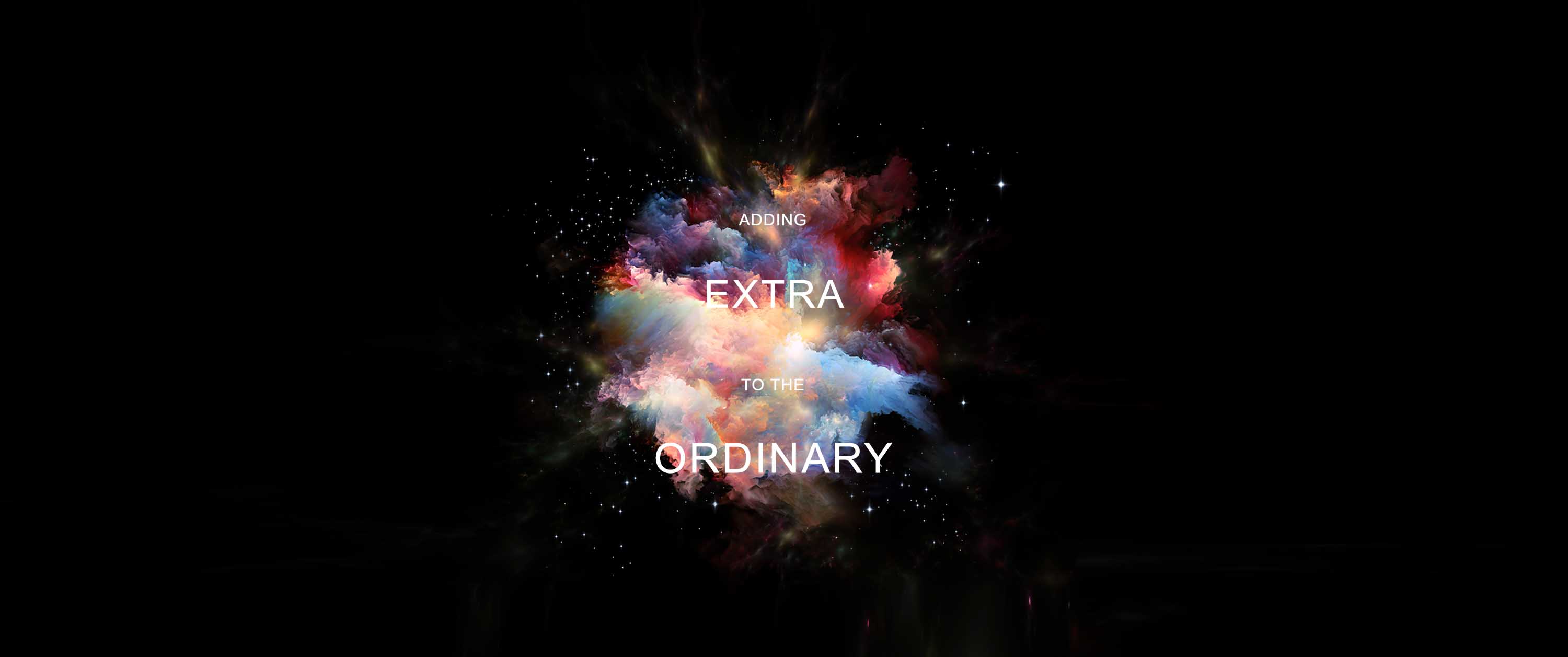Revenge porn: breve storia di un reato
Si chiude così la settimana del 25 novembre, dedicata all’eliminazione della violenza di genere, alle donne, a storie di donne, a storie di vita spesso distrutte da superficialità e violenza ingiustificata. Nella nostra consueta puntata radio del lunedì in collaborazione con RadioUnint – e grazie all’importante contributo della speaker Jessica che ha approfondito e affrontato queste tematiche nella sua tesi di laurea – abbiamo discusso della violenza di genere e del sostrato culturale, dell’impatto e sociale e degli ordinamenti giuridici connessi a un reato sempre più diffuso: il revenge porn.
Fin dall’antichità, il fenomeno della violenza sulle donne si è manifestato in diverse forme ed intensità, tanto da scuotere l’attenzione e la coscienza di molti. Si tratta, infatti, di un problema sociale universalmente condiviso in quanto “colpisce” donne di qualsiasi ordine, classe ed età. La nota distintiva di tale criticità sta nel fatto che si tratta di una forma di violenza basata sul genere. Le donne vengono umiliate, maltrattate, perseguitate ed uccise in quanto donne. Alla base vi è una cultura maschilista e discriminante che trova le fondamenta nella disparità tra uomo e donna, nel considerare il sesso femminile come inferiore e, perciò, da subordinare. L’approccio di genere, quindi, ci consente di divenire soggetti consapevoli di tale realtà e, soprattutto, di attivarci concretamente per cambiarla. È importante sottolineare che l’inclusione del concetto di genere nelle definizioni internazionali di violenza è frutto di un percorso storico e rappresenta un’importante acquisizione la cui espressione culminante è rappresentata dalla Convenzione di Istanbul, un documento che stabilisce degli standard internazionali per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne.
Nello specifico una vicenda che ha avuto tristemente risonanza nelle ultime settimane arriva dalla provincia di Torino ed è una lunga storia di tradimenti, vendetta e superficialità; è in atto un processo che indaga cinque persone che rispondono di violenza, divulgazione di materiale privato e diffamazione.
È il 2018 quando una ragazza conosce un calciatore dilettante del paese e gli invia immagini erotiche ed un video. Si tratta di una maestra il cui nome, sul telefono dell’ex e degli amici di calcetto con cui lui ha condiviso il materiale privato, rimane legato all’immagine e il video. La moglie di uno dei calciatori a cui il materiale arriva riconosce nella donna la maestra d’asilo del proprio figlio, arrivando a minacciarla e gridando alla scandalo. La maestra non si lascia intimorire, presenta querela e si aspetta comprensione dalla preside scolastica che invece la convince a rassegnare le dimissioni.
Il punto di partenza della vicenda è che nel sesso, libero e consensuale, non c’è vergogna; vergogna che invece dovrebbe provare chi viola il diritto privato, tenendo a mente l’esito tragico delle vicende di Tiziana Cantone. È piuttosto necessario decostruire una serie di stereotipi introiettati nel corso del tempo che vengono percepiti come normalità; bisognerebbe partire dalle scuole e dall’educazione per arrivare a una sana concezione della sessualità nel rispetto delle libertà individuali. Il sesso assume ad oggi – purtroppo – una valenza sociale negativa ancorata all’idea di peccato, di vizio e di indecenza fino al punto che la maestra è stata considerata inadatta a ricoprire un ruolo di educatrice istituzionale.
Per “revenge porn”, infatti, si intende un’azione esercitata mediante la diffusione di immagini o video che ritraggono la vittima in atteggiamenti intimi. Le conseguenze di tale fenomeno sono disastrose per la donna, la quale viene offesa e privata della propria privacy. Il fine di simili condotte è quello di denigrare e screditare l’identità della donna in quanto tale, umiliandola difronte ad un numero non quantificabile di persone. La pericolosità di tale fenomeno, pertanto, è data dalla indefinita quantità di soggetti che può raggiungere. Questo è uno degli aspetti che più preoccupa le vittime, in quanto una foto o un video, soprattutto se diventa virale, può scatenare una “gogna mediatica” dalla quale è davvero complicato trovare uno spiraglio di luce. Ad oggi, diverse sono le notizie di cronaca che riportano episodi di simili violenze e in casi non troppo isolati, purtroppo, la vittima vede nel suicidio l’unico modo per uscire da una realtà fatta di insulti, minacce e denigrazioni. È bene tenere a mente, quindi, che la rete non dimentica; tutto il materiale intimo o privato che viene pubblicato e fatto circolare su internet, infatti, è molto difficile da eliminare in modo permanente e può avere ripercussioni devastanti e irreversibili per la vita dei soggetti colpiti.
Il revenge porn è a tutti gli effetti un reato, sebbene sia affrontato spesso con superficialità dagli stessi utenti social; basti pensare ad uno degli amici del calcetto nella vicenda di Torino che ha definito l’azione di diffusione del materiale erotico come “una goliardata da uomo”. L’ordinamento italiano, in realtà, mette a disposizione e disciplina, all’interno di diversi testi legislativi tra cui il Codice penale, il codice di procedura penale, il Codice civile e alcune leggi speciali, molteplici strumenti atti a reprimere una serie di reati ascrivibili al fenomeno della violenza maschile contro le donne. In tempi più recenti l’ordinamento italiano ha approvato la legge n. 69 del 19 luglio 2019 che prevede numerose modifiche alle normative riguardanti la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Entrata in vigore nell’agosto 2019, tale legge, meglio conosciuta con l’espressione “Codice Rosso”, si compone di 21 articoli e presenta alcune novità importanti. Tra queste, viene introdotto l’articolo 387-bis del Codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; viene poi riconosciuto come reato, mediante l’inserimento dell’articolo 612-ter del Codice penale, il fenomeno della revenge porn.
Parlarne, legiferare in merito e discuterne è quindi indispensabile per sdoganare determinati tabù perpetuati del tempo, nella protezione e tutela di tutti i diritti indisponibili del singolo. L’obiettivo, pertanto, rimane quello di eliminare ogni forma di prevaricazione contro le donne e di fondare una realtà dove le stesse possano riconoscersi come persone e non come oggetti da subordinare.
Jessica Sebastiani ed Evelyn De Luca