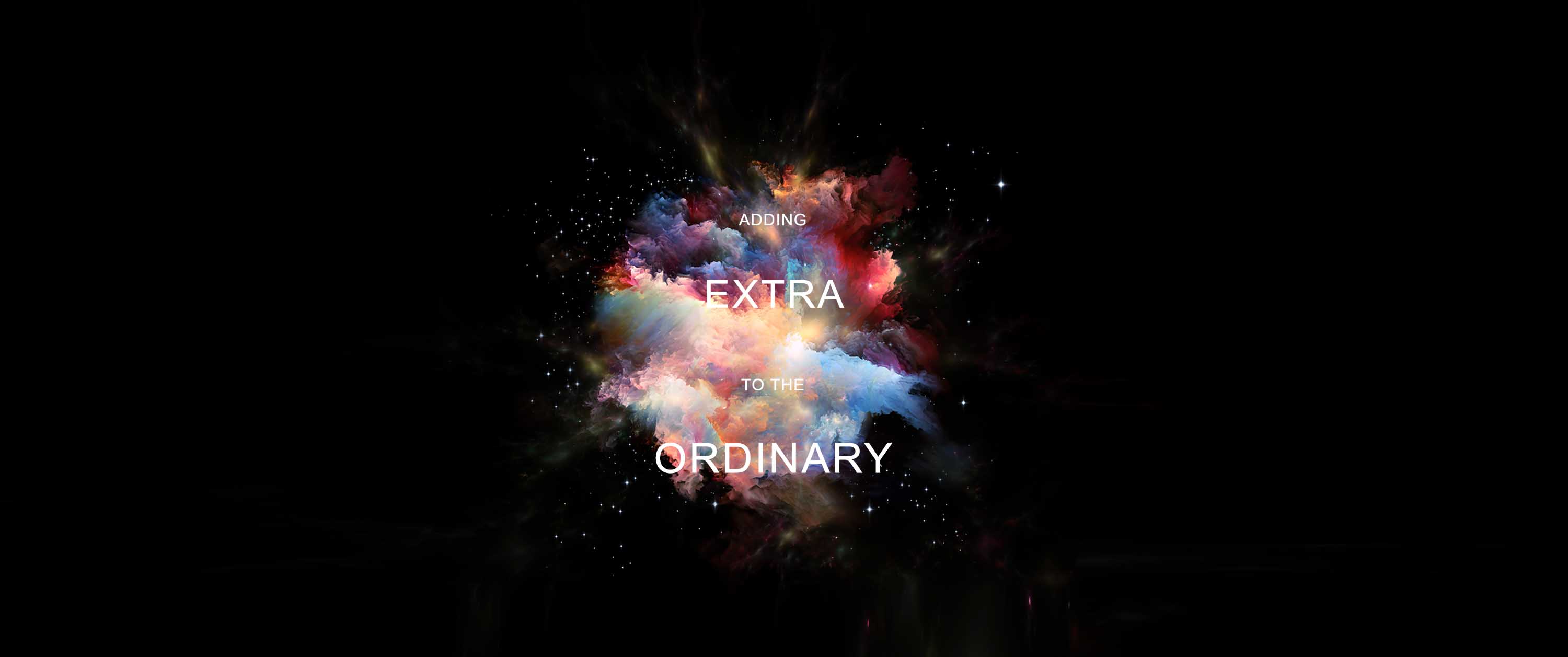Categoria: Archivio
#FACCIAMOILPUNTO 29novembre
Pubblicato ilEdizione speciale…. #VALE LA PENA

Il tempo sta volando e anche novembre volge al termine.
Si inizia a parlare di esoneri e appelli d’esame, ma mancano solo cinque venerdì a Natale quindi, consoliamoci. Nel frattempo, il mondo è diviso.
Una buona parte va a fuoco, è in rivolta. Mentre l’Italia annega sotto le incessanti piogge.
Martedì 19 Novembre l’UNINT ha avuto l’opportunità di partecipare ad un momento conviviale nell’ambito della Terza Missione.
Per chi non lo sapesse: si parla di “terza missione” dell’Università, per sottolineare che gli atenei devono assumere un nuovo fondamentale obiettivo accanto a quelli della didattica e della ricerca scientifica: il dialogo con la società.
In particolare, in questa occasione, l’UNINT si è messa in contatto con il mondo del disagio carcerario incontrando i dipendenti e i coordinatori della birreria artigianale “Vale la pena”.
“Può creare indipendenza” è il loro motto e nasce nel 2014 all’interno della Onlus Semi di Libertà con l’obiettivo di contrastare le recidive delle persone in esecuzione penale. All’interno di questo progetto, detenuti ammessi al lavoro esterno vengono formati ed avviati all’inclusione professionale nella filiera della birra artigianale.
Noi di UNINT Blog e Radio UNINT abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Oscar La Rosa, fondatore di Economia carceraria e Massimo, che ha vissuto in prima persona da un lato il disagio carcerario e dall’altro le opportunità date dal progetto.
Oscar, raccontandoci di “come siamo arrivati fin qui” ci ha detto che:
“Il carcere, è un luogo che esiste effettivamente in Italia, ed è un luogo di cui spesso e volentieri ci dimentichiamo. Lì dentro vivono delle persone, quindi c’è una componente umana che va ricordata in qualche maniera.
E in Italia, il carcere non funziona.
Qual è il fattore per vedere se una politica pubblica funziona oppure no? Si va a prendere il dato sulla “recidiva”. Si va a vedere se queste persone, una volta uscite dal carcere, tornano a commettere reato oppure no. Se tornano in galera significa che quegli anni spesi nel carcere non sono serviti a tanto, se invece non tornano significa che in quegli anni è stato fatto un buon lavoro.
Ecco, questo dato, in Italia, al 2005, è del 70%. Ovvero il 70% dei detenuti usciti dal carcere nel 1998 ci è rientrato nel 2005. Questo dato è molto alto, e la cosa che ancora più fa impressione è che da 20 anni non si hanno statistiche ufficiali sulla recidiva.
Parliamo quindi di dati vecchi, che il Ministero non ha più analizzato, e quindi ad oggi non sappiamo se siano aumentati o diminuiti. Ma da quello che possiamo vedere la situazione non è buona.
Uno degli strumenti fondamentali per contrastare questa tendenza, e il più efficace a mio avviso, è il lavoro carcerario. Questo assicura una pena dignitosa, perché il lavoro permette di avere un reddito e di continuare a contribuire in qualche maniera alla famiglia che è rimasta fuori, considerato anche che il 95% dei detenuti è di sesso maschile.
Il lavoro in carcere per come lo intendiamo noi, ovvero il lavoro alle dipendenze di una cooperativa, quindi all’esterno del carcere e non verso l’amministrazione carceraria, è fondamentale per far capire al detenuto le regole del mondo libero. Ovvero l’avere diritti e doveri nei confronti di un’altra persona, il datore di lavoro.
Lo stigma è un’altra questione preoccupante: chi esce dal carcere è socialmente segnato da questa esperienza, quindi un’azienda sarà sempre portata a compiere scelte alternative nel momento delle assunzioni.
Da qua nasce l’idea di economia carceraria, e di questo luogo.
Ci siamo chiesti: come combattiamo questo stigma? È la risposta più naturale è stata creare un posto dove possiamo parlare di questi temi. Partecipare a fiere, eventi, con i ragazzi che provengono dalla realtà carceraria e mettendoli in contatto, senza filtri, con la società civile.
Economia carceraria nasce un anno fa, con il primo Festival che si è svolto il 2 giugno 2018 a Roma. Ed è nata da un’idea molto semplice, forse banale. Ci siamo incontrati io e Paolo Strano (il fondatore della Onlus Semi di Libertà che ha curato e lanciato il progetto di “Vale la pena birra” ndr.) e ci siamo detti “Invitiamo le varie cooperative coinvolte nell’economia carceraria e creiamo una tavola rotonda per capire meglio com’è la situazione carceraria in Italia e quali sono le politiche pubbliche a riguardo”. In questo modo volevamo dimostrare alla società civile che all’interno del carcere esisteva una realtà produttiva, e anche accademica, dal grande potenziale.
Questo festival ha avuto un grande successo, soprattutto dal punto di vista mediatico, e quindi abbiamo sentito la necessità di iniziare a pubblicizzare e a vendere i beni prodotti all’interno delle varie carceri in Italia.
L’idea di base è che anche la vendita di un semplice pacco di biscotti può garantire ad una cooperativa la possibilità di assumere un nuovo detenuto.
Per questo, da un anno lavoriamo per vendere questi prodotti, sia nel nostro pub, ma anche all’interno di negozi equo-solidali.
Mai come in questo caso è vero il detto: “L’unione fa la forza”.
Perché poi, la vera sfida per noi è “integrare” e non ghettizzare, fondere insieme persone libere e persone detenute, per fare in modo che le une esaltino le altre.”
Come è nata l’idea della produzione di birra?
“L’idea della birra nasce da Paolo, il fondatore di questa Onlus.
È un fisioterapista, per motivi di lavoro va al Regina Coeli a curare i detenuti ed è rimasto colpito dal fenomeno delle “porte scorrevoli” ovvero, appunto, della recidiva.
Paolo ha individuato nel lavoro lo strumento migliore per contrastare questa tendenza ma era il 2012, ovvero il punto più alto della crisi occupazionale in Italia. Si accorge però che un settore occupazionale in crescita c’era, ed era quello della produzione di birra artigianale.
Basti pensare che nel 2012 i birrifici artigianali in Italia erano 300, mentre ad oggi abbiamo superato i 1400. Questo ha permesso di dare vita ad un progetto non solo formativo, ma soprattutto auto-sostenibile. Questa estate Birra Vale la pena è diventata un’azienda vera e propria con l’obiettivo di crescere e di assumere sempre più detenuti, ed ex detenuti.
Il momento più critico per un detenuto infatti non è quando è in carcere, ma quando sta per uscire.
Molte persone che sono passate da qui, dalla Onlus, erano spaventate dal “fine pena” perché a quel punto non avrebbero più potuto lavorare con noi. Per questo motivo abbiamo fortemente voluto lavorare “fuori dal carcere” per poter accompagnare questi ragazzi nel momento più tragico dell’intera esperienza, ovvero il momento dell’uscita.”
Massimo invece, ci ha raccontato della sua esperienza personale:
“L’uscita è il momento più critico ma dipende anche da chi ha i mezzi e da chi non. E non parlo di quelli esclusivamente materiali, economici.
All’uscita dall’istituto ho trovato delle amiche che mi hanno parlato della Onlus Semi di Libertà, per la quale ho subito iniziato a fare il volontario, per un certo periodo. Poi le nostre strade si sono dovute dividere perché io ho trovato lavoro, ma non appena è nato l’idea (Vale la pena) ho sentito il bisogno di farne parte, perché me ne ero innamorato.
Ad oggi stiamo cercando di destinare una parte di questo progetto al finanziamento del Pub e un’altra parte alla valorizzazione dei prodotti che vengono da Economia carceraria.
A me piaceva l’idea che qualcuno si dedicasse, senza interessi economici, a persone che avevano bisogno di abituarsi nuovamente all’ambiente esterno. Poi è ovvio, non possiamo aiutarne 100 mila, ma anche se ne aiutiamo 5, io sono felice.”
Alla nostra domanda “In che modo il mondo universitario da cui proveniamo potrebbe aiutarvi?”
La loro risposta è stata: “Da clienti, innanzitutto!”.
quindi andiamo a trovarli, numerosi, al Pub Vale La Pena Birra in VIA EURIALO 22.
Anche perché la birra è davvero buona… Parola di UNINT Blog!
#PeopleOfUNINT
Pubblicato il
Nella mia vita ho sempre cercato di comprendere da cosa derivi la mia
ammirazione verso l’apprendimento di una nuova lingua e cosa esattamente mi affascini di più di questa: se la cultura o la grammatica in sé. Sin dagli anni delle elementari, quando la maestra ci faceva giocare a
bingo per memorizzare i vocaboli in inglese, è sempre spiccata la mia
propensione verso lo studio delle lingue.
Credo che l’infanzia sia una fase importante della vita, poiché mette in luce le abilità e spesso e volentieri anche gli interessi di una persona. Durante questo periodo infatti il bambino non ha sviluppato una consapevolezza tale da poter dire cosa vuole fare della sua vita ma è proprio da questo suo limite di irrazionalità che riesce ad esprimere molto di più della sua persona. Quando si diventa grandi si avverte spesso l’influenza dei genitori o della società sulle proprie scelte; mentre da bambino tutto scorre in maniera più naturale.
Ricordo ancora quel giorno a tavola con mamma e papà: stavamo
cenando e come ogni sera decisero di accendere la tv per ascoltare le
notizie del giorno al telegiornale. Io ero affascinata dalla parte dell’inviato
speciale che appariva per testimoniare sul luogo dell’accaduto. Dissi a
mamma che quello era il lavoro che volevo fare ma feci una precisazione: “lo voglio fare in una lingua diversa dall’italiano!” Mamma scoppiò a ridere ed iniziò a farmi centinaia di domande sul perché scelsi proprio quel mestiere (che poi “scelsi” è un parolone dal momento in cui a quei tempi l’unica certezza che avevo era che frequentavo la prima media e avevo soli undici anni!). Io amavo viaggiare e soprattutto nei viaggi cimentarmi nelle mie ancora limitate abilità linguistiche. Forse vedevo nel ruolo dell’inviato ciò che potesse soddisfare questi miei interessi.
All’età di diciannove anni le mie idee ed i miei sogni si sono piano piano trasformati ed in parte esauditi. Innanzitutto ho avuto la possibilità di frequentare un liceo che mi ha insegnato tanto, non solo sulla base delle lingue, ma soprattutto a livello umanistico. Con questo mi riferisco alle acquisizioni di materia filosofica, storica e letteraria che reputo di estrema importanza per sviluppare la propria personalità individuale. Una più consapevole introspezione mi ha permesso quindi di riscoprire i miei desideri, che seppur in linea con quelli che coltivavo da bambina, risultano in parte cambiati. Nel corso degli studi superiori ho iniziato ad interessarmi maggiormente sul tema politico-economico, tanto da voler capire sempre di più la realtà che mi circonda. Nonostante questo però la mia passione per le lingue non è svanita ma anzi si è plasmata intorno a quest’ambito più specifico. Ho maturato così l’idea di sfruttare e coltivare le mie conoscenze linguistiche in un contesto più ampio legato all’ambiente politico internazionale.
Questa è la strada che ho deciso di intraprendere oggi, con la scelta di un’università che mi permette di lavorare sulle lingue e allo stesso tempo sulle materie di carattere politico-economico. Spesso mi fermo a pensare quali siano i fondamenti di una passione così forte che mi accompagna dall’età dell’infanzia, addirittura per lingue che non hanno alcuna affinità con l’italiano. Reputo che sia stato molto influente per me l’ambiente familiare dove sono cresciuta. Mamma mi lasciava spesso con la nonna quando andava a lavorare ed io passavo lunghe giornate insieme a lei nell’hotel di famiglia. Ho sempre ammirato sia mia nonna che i miei zii perché sapevano parlare in ben tre lingue diverse fluidamente. Probabilmente è da qui che ho incominciato a maturare il mio sentimento nei confronti delle lingue che mi hanno sempre dato tanta soddisfazione nel metterle in pratica.
La lingua che considero attualmente la mia preferita è il russo ed in tanti mi chiedono come faccia a piacermi una lingua così complicata dal punto di
vista dell’alfabeto, della grammatica e dell’articolazione dei suoni. Io non trovo mai la spiegazione giusta da fornire: mi piace e basta. Mi piace perché
le parole scorrono fluide, perché così come in tedesco dove sono presenti i
casi, mi viene semplice comporre le frasi ma soprattutto mi affascina tanto
quella loro cultura, che seppur rigida, è fatta di tradizioni che mi ispirano un senso di tranquillità e calore. Quando penso alla Russia mi appare alla mente l’immagine di un dolce momento di serenità con amici e parenti mentre si sorseggia una tazza di tè, guardando fuori dalla finestra la neve che ricopre di bianco gli alberi del giardino.
Apparentemente sembra la scena di un tipico film natalizio ma in realtà è una tradizione culturale del Paese; così come quella della sauna all’interno delle abitazioni di campagna, luogo prediletto per un weekend fuori città.
Mi piace venire a contatto con altre culture ed integrarmi al meglio
all’interno di un Paese diverso dal mio ma ci tengo altrettanto a diffondere le mie tradizioni e la mia cultura che difendo con tanto orgoglio.
Vorrei che in un futuro questo mio legame che sento e nutro sin da bambina nei confronti delle lingue, possa realizzarsi un giorno in un lavoro che metta in comune esse con la mia lingua madre.
Questo è il mio sogno ed il mio obiettivo che senza pretese per la mia vita mi impegnerò a raggiungere in ogni modo.
#25Novembre: Giornata internazionale per eliminare la violenza contro le donne
Pubblicato il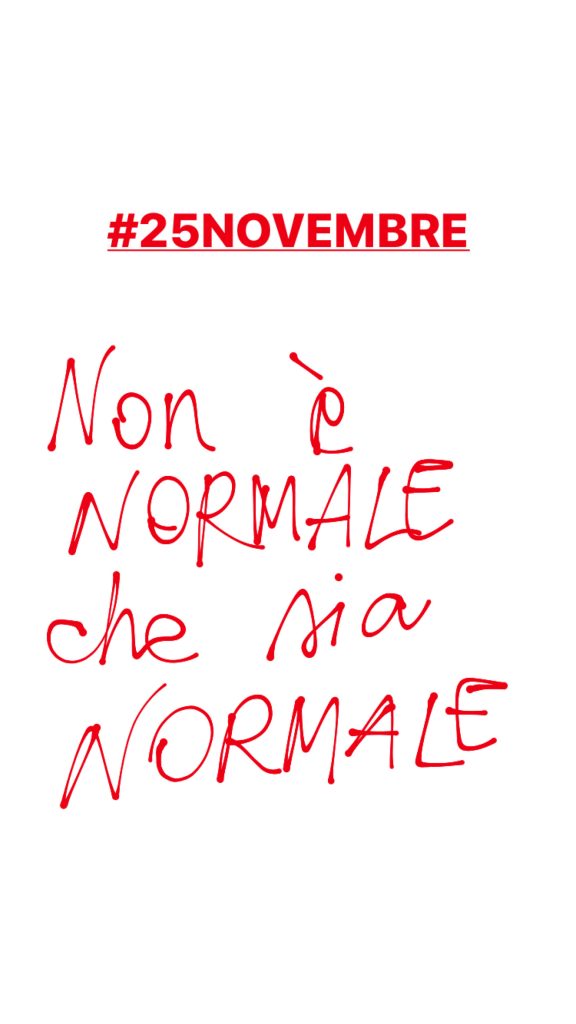
“Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società.” – Rita Levi-Montalcini
MondayAbroad cambia rotta: in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (deliberata nel 1999 dalle Nazioni Unite), vorrei soffermarmi sulla grande importanza del gentil sesso, anche se non sempre riceviamo le attenzioni adeguate. L’evoluzione del ruolo e dello status della donna ha mutato profondamente la nostra società nella sua struttura più profonda ed essenziale, basti pensare, per esempio, all’antica differenza tra donna schiava e donna libera, tipica del mondo latino.
La violenza contro le donne è ritenuta violazione dei diritti umani e coinvolge donne e bambine, anche se non è da confondere con la violenza di genere, la quale riguarda anche i minorenni, come, per esempio, nei casi di violenza assistita.
L’articolo 1 della Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne approvata dall’ONU nel 1993 descrive la suddetta violenza come: «Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata.»
Esistono, ahimè, troppi tipi di violenze, tra cui, per esempio, la violenza domestica (che rappresenta il comportamento abusante di uno o entrambi i compagni in una relazione intima di coppia che, in molti casi, sfocia nell’omicidio, esercitata soprattutto attraverso minacce, maltrattamenti fisici e psicologici, atti persecutori, abusi sessuali ecc.) e la violenza economica (consiste nel controllo del denaro da parte del partner, nel divieto di intraprendere attività lavorative esterne all’ambiente domestico, al controllo delle proprietà e al divieto ad ogni iniziativa autonoma rispetto al patrimonio della donna).
In moltissime società tradizionali, la donna si trova in una condizione di inferiorità in famiglia, che spesso è stabilita dalla legge: nella maggior parte dei paesi arabi la poligamia è ancora ammessa; in Arabia Saudita una donna non può viaggiare all’estero senza il permesso scritto di un parente maschio. In India e in Cina, invece, si concretizza l’aborto selettivo (ossia l’obbligo di partorire solo figli maschi in quanto riconosciuti e accettati socialmente).
A partire dagli anni settanta del XX secolo il movimento delle donne e il femminismo in Occidente hanno iniziato a mobilitarsi contro la violenza di genere, sia per quanto riguarda lo stupro sia per quanto riguarda il maltrattamento e la violenza domestica. Il movimento ha messo in discussione la famiglia patriarcale e il ruolo dell’uomo nella sua funzione di “marito/padre-padrone“, non volendo più accettare alcuna forma di violenza esercitata sulla donna fuori o dentro la famiglia. In questi anni vengono istituiti i primi Centri antiviolenza per le donne vittime di violenza (anche se in Italia nasceranno solo a fine anni Novanta).
Per quanto riguarda l’istruzione, invece, si parla soprattutto di analfabetismo sviluppatosi nei paesi in via di sviluppo africani: benché la percentuale di analfabeti sia molto diminuita negli ultimi decenni, sia tra i maschi sia tra le femmine, le differenze rimangono molto forti, tant’è che sono ancora circa la metà le donne analfabete, mentre gli uomini sono solo il 30%. Le cause di questa diseguaglianza sono riconducibili ad un retaggio culturale e sociale legato a modelli tradizionalmente patriarcali, secondo i quali la donna deve occuparsi delle mansioni legate alla casa, al benessere dei familiari, alla cura dei genitori anziani e dei bambini. Detto ciò, è facile proseguire il tema trattato arrivando a parlare delle discriminazioni in ambito lavorativo: molte donne, non solo delle culture africane, decidono di dedicarsi esclusivamente alla casa ed alla famiglia. Ma che cosa succede a chi, invece, ha un altro sogno?
Art. 37 Costituzione: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.
Negli anni, dalla conquista del diritto al voto, le donne hanno sempre più visto crescere i loro diritti e il loro ruolo nella società. Nulla di più vero ma anche nulla di più contestabile. In Italia non vi sono “palesi” discriminazioni, né sul posto di lavoro né nella vita ma guardando più a fondo i dati si scopre che solo il 22% dei dirigenti in Italia sono donne, contro il 78% degli uomini (Fonte: Il Sole 24 Ore).
econdo il rapporto dell’Osservatorio di JobPricing, il differenziale tra le buste paga di maschi e femmine è di quasi 3.000 euro lordi annui. L’Osservatorio la chiama una “discriminazione salariale tout-court”, slegata dunque dalla collocazione in settori meno “ricchi” e dai ruoli. In più c’è un altro fatto: le donne sono prevalentemente occupate in settori non industriali (servizi, servizi finanziari, commercio), dove però molto spesso i differenziali retributivi sono ancora più elevati. Dove le donne sono di più, dunque, i loro stipendi sono comunque più bassi di quelli dei colleghi uomini. A fronte di un dibattito acceso e ricorrente sulla questione della parità di genere, il principale indicatore, e cioè il livello retributivo, marca ancora un netto divario fra i sessi. Tutto questo stona con un principio: la parità di genere rappresenta uno dei valori fondamentali dell’Unione Europea. Eppure, sul lavoro la realtà è diversa. Nella Ue le donne, nei vari settori economici, guadagnano in media oltre il 16% in meno all’ora rispetto agli uomini. Molti ancora oggi pensano che le imprese non tendano a discriminare le donne perché sono obbligate dalla legge e dai contratti collettivi a pagare lo stesso salario a donne e uomini che svolgono la stessa mansione, difatti più alto è il ruolo ricoperto, più grosso è il divario, fino a giungere alle retribuzioni più alte dove il suddetto divario arriva al 17% in meno degli uomini.
Eppure è un vecchio problema, ancora irrisolto: risale, difatti, al 1975 la direttiva sulla parità retributiva tra uomini e donne della Comunità Europea, ma a oltre quarant’anni di distanza dall’introduzione dei primi provvedimenti legislativi per la parità di stipendio, il differenziale salariale per sesso (gender pay gap) rimane un aspetto cruciale che le donne si trovano a dover affrontare nel mercato del lavoro. La differenza salariale di genere entra, dunque, a pieno titolo nelle agende di lavoro di tanti Stati, dopo che l’Unione Europea da anni ha posto l’accento sul tema, tanto da creare un progetto ad hoc per sensibilizzare i Paesi membri: in Gran Bretagna, per esempio, le grandi aziende sono obbligate a pubblicare i dati sul differenziale di genere nei salari e nei bonus dei loro dipendenti.
Insomma, le donne hanno sempre dimostrato di essere pazienza e intraprendenza, maternità e orgoglio, figure fondamentali non solo per uno scopo riproduttivo. Oggi, giornata contro la violenza rivolta nei loro confronti, voglio cogliere l’occasione per incoraggiare tutte coloro che hanno fiducia nel domani: non siamo sole, non dimentichiamolo mai.
Siamo potenza, energia e luce; siamo passione, dolcezza e sensualità; siamo intelligenza, aspirazione e coraggio; siamo bambine, ragazze e adulte. Siamo questo e molto più.
Ilaria Violi
#PeopleOfUNINT: Flavia Zollo
Pubblicato il
Le lingue sono come fiumi: maestose e dirompenti. Bisogna lasciarsi travolgere e viverle appieno. Le lingue, infatti, non devono essere solo studiate, ma devono anche essere vissute. Bisogna immergersi in esse. Con la propria “materna lingua”, come la chiamavano i latini, è più facile nel momento in cui si cresce in un Paese in cui si parla tale lingua. Più complesso è lasciare entrare lingue straniere. Sono appunto dei fiumi che arrivano dentro di noi, rendendo la nostra vita infinitamente più ricca, ma anche più complessa. Me ne sto accorgendo sempre di più grazie al nuovo percorso di studi che ho intrapreso. Scegliere una facoltà di lingue è una presa di posizione in qualche modo. Tutti dicono che sia molto importante conoscere le lingue per entrare nel mondo del lavoro e quindi i giovani cercano di affiancarle alle abilità che costruiscono grazie ai percorsi universitari scelti. Ma il tempo non è mai abbastanza. Scegliere lingue all’università vuol dire rendere il loro studio centrale nella propria vita e chi lo fa deve imparare a conoscerle nel profondo se vuole fare la differenza.
Ma cominciamo dall’inizio di questa mia biografia linguistica. Non ho la fortuna di essere bilingue, ma ognuno ha la propria storia e sono tutte uniche.
La lingua con cui sono nata, la mia lingua madre, è l’italiano. È dentro di me e prima ancora è sempre stata anche intorno a me. È ben radicata ed è istintivo utilizzarla. Il processo di apprendimento è stato da una parte naturale, dall’altra guidato dalla scuola e dalla grammatica. Ma una lingua è molto di più. Essendo madrelingua italiana, posso andare oltre la struttura linguistica, oltre il parlato. Penso che sia molto affascinante e interessante apprendere la storia della propria lingua, scoprire le etimologie, i perché che si celano dietro i suoni che pronunciamo. Le parole ci parlano e io voglio ascoltarle.
I miei genitori sono italiani, di Roma, così come i miei nonni materni. Invece, dalla parte di mio padre, mia nonna è marchigiana e mio nonno campano. Avendo vissuto fin da giovani a Roma, hanno perso molto la loro cadenza, soprattutto mia nonna. Hanno cresciuto i loro figli senza un accento particolare. Il dialetto campano, però, è rimasto in tutta quella parte della famiglia che ha continuato a vivere vicino ad Avellino. Ed è lì che l’ho sempre sentito, dai miei parenti “di giù”. Quando ci troviamo in loro compagnia, si verifica un incontro a metà strada: loro parlano in italiano senza termini tipicamente dialettali ma con una forte inflessione e mio padre tende ad assumere il loro “spirito linguistico”. Infatti, pur avendo sempre vissuto a Roma, da ragazzo trascorreva l’estate in Irpinia e quindi in queste occasioni di ritrovo riemerge una sua parte linguistica che di solito è latente. È questo che avviene con i dialetti. Io rimango particolarmente neutrale proprio perché non ho quella parte linguistica che possa rispondere a questo tipo di richiamo.
Con mia madre apriamo un altro capitolo. Parla, oltre all’italiano che è la sua unica lingua madre, l’inglese, lo spagnolo e il francese. Per tutta la sua vita ha usato queste quattro lingue quotidianamente nel suo lavoro. Fin da piccola sono stata colpita da queste sue capacità linguistiche e lei mi ha sempre trasmesso il suo amore per le lingue. Mi ha donato solo l’italiano come lingua madre, ma fin da quando ho memoria mi parlava spesso anche in inglese, spagnolo e francese, anche solo per giocare. Mi ha permesso così di affacciarmi su quei mondi apparentemente lontani, che per la me bambina facevano parte del mio unico mondo. Crescendo, mi divertivo a parlare con lei in una delle tre lingue straniere, soprattutto durante viaggi di famiglia all’estero per fingere di essere del luogo.
Ritornando alla mia scelta universitaria, ho deciso di studiare proprio queste tre lingue: l’inglese, lo spagnolo e il francese.
L’inglese è il mio fedele compagno di vita dall’età di cinque anni. Non mi ha mai lasciata. È stato amore a prima vista e l’ho accolto dentro di me nel corso degli anni. Non essendo una lingua romanza, è abbastanza diverso dall’italiano e questo, ho sempre pensato che fosse un vantaggio per non confonderla con l’italiano stesso. L’ho imparato alle elementari come la maggior parte dei bambini italiani e ho continuato a studiarlo alle medie e al liceo, affiancando corsi pomeridiani per intensificarne lo studio scolastico limitato. Negli ultimi anni ho trovato un grande alleato in YouTube per ascoltare persone madrelingua inglesi che parlano della loro vita vera. Questo mi ha permesso di entrare nella realtà inglese pur rimanendo in Italia.
Il francese è arrivato in prima media. A quel tempo non amavo lo spagnolo (non lo aveva ancora osservato bene) e quindi scelsi il francese, lingua che trovavo alquanto musicale. Tre anni, anche se intensi e con validi risultati, non sono stati sufficienti a far sì che rimanesse in me, non continuandolo al liceo. Lo sto ora riscoprendo all’università.
Per quanto riguarda lo spagnolo, il discorso si fa più complesso e appassionante. Non l’ho mai studiato a scuola, ma durante il mio primo anno di liceo me ne sono innamorata guardando una serie tv argentina. Non volevo guardarla in italiano perché il doppiaggio, pur essendo un’arte, toglie molta veridicità alle storie che vengono raccontate e in più volevo sentire di star facendo qualcosa di utile. E così scoprii una delle lingue più belle al mondo. Capivo praticamente tutto, aiutata anche dal fatto che l’accento argentino è più semplice rispetto ad altri accenti del mondo ispano-americano. Si può dire, quindi, che io abbia imparato l’argentino con la sua pronuncia e il suo lessico. Mi sono follemente innamorata di questa lingua e non ho più smesso di scoprirla. La scorsa estate, l’estate del 2019, sono andata a studiare in Spagna, soprattutto per avere un primo approccio alla grammatica e costruire delle basi solide, e sono rimasta colpita dalle grandi differenze con l’argentino, ma pian piano ho imparato a calarmi nel mondo spagnolo di Spagna e questo mondo mi ha conquistata. Vivendo lì, anche se per poco, mi sono resa conto di quanto sia importante andare all’estero per imparare le lingue e cercare di parlare sempre in quella lingua senza ritornare all’italiano per tutto il periodo della permanenza nel Paese straniero.
Questo studio intenso delle lingue, che si intensificherà sempre di più, è arrivato così prepotente solo nell’ultimo periodo. Infatti, avendo frequentato il liceo classico, negli ultimi anni ho continuato a studiare l’inglese, ma nessun’altra lingua moderna. In compenso, mi sono dedicata al latino e al greco, due lingue che purtroppo si stanno mettendo sempre più da parte. Una delle ragioni è che non possiedono più la sfera orale (a meno che non si tratti di percorsi più specifici e di livello molto elevato). Sono addirittura definite “lingue morte”, quando invece sarebbe più corretto dire “eterne”.
Le lingue sono il mezzo di comunicazione più potente che ci sia, uno strumento fondamentale per entrare in contatto con gli altri in qualsiasi situazione ci si trovi, da un viaggio a un lavoro. Quello che si fa è uno sforzo per andare incontro a coloro che parlano una lingua diversa dalla nostra. È un modo per fare amicizia, per trovarsi in ambienti internazionali, per scoprire le altre culture. Un momento parliamo una lingua e quello successivo passiamo ad un’altra. È sorprendente come il nostro cervello ci consenta tutto questo e come arrivi addirittura a permetterci di pensare nella nostra quotidianità in un’altra lingua, di fare discorsi con noi stessi in un’altra lingua. È una delle cose che preferisco di più al mondo.
#MondayAbroad: Leo Dossini
Pubblicato il
Nato da mamma francese e papà italiano, oggi conosciamo Leo, studente Erasmus proveniente dalla Facoltà di Interpretariato e Traduzione dell’Université de Lille.
Chiacchierare con Leo è molto divertente: è un ragazzo molto simpatico e solare, allegro e scherzoso, che non fa fatica ad aprirsi con me sulla sua esperienza.
“Sono qua con la mia fidanzata, anche lei è in Erasmus, ma in un altro ateneo. Ci stiamo divertendo molto in quest’avventura: stiamo crescendo e stiamo capendo ogni giorno di più cosa vuol dire essere adulti, dunque, cosa significa doversi occupare anche della casa, per esempio… è comunque bello avere responsabilità alla pari con la nostra età.”
Leo rimarrà con noi tutto l’anno, arrivando a dare un totale di otto materie: “non ho trovato grossi ostacoli nella compilazione del mio Learning Agreement e, per fortuna, sia i miei docenti francesi che questi italiani si sono sempre resi molto disponibili per aiutarmi in caso non riuscissi a completare qualche passaggio.”
Come già detto, Leo ha una buona percentuale di italianità che scorre nelle sue vene: “amo l’Italia e sono molto fiero delle mie origini. Mio papà ci portava spesso a Bologna e qualche volta è capitato che visitassimo anche altre città italiane, infatti non è la prima volta che venivo nella Capitale.”
Incuriosita, comunque, dagli elogi che Leo continuava a rivolgere alla sua cittadina francese, ho deciso di continuare l’intervista spostandomi dall’obiettivo principale per parlare di… cibo e feste! (Quindi occhio alle prossime righe, lettori viaggiatori e buongustai!).
Lille è, infatti, conosciuta come una città universitaria, capoluogo della regione Alta Francia, ma è anche famosa per la Braderie de Lille, nella quale 10.000 espositori, fra cui 300 venditori professionisti di oggetti di brocantage, offrono un centinaio di chilometri di bancarelle a quasi 3 milioni di visitatori per vendere e comprare di tutto, dando vita a uno dei mercati delle pulci più grandi d’Europa e che consente alla città di Lille di trasformarsi in un’immensa isola pedonale dove commercianti, rigattieri e appassionati di antiquariato di ogni genere portano avanti una tradizione commerciale e di festa, mangiando cozze, patatine e moules-frites, e per Lille 3000, una gigantesca sfilata che cambia ogni anno tema e che attrae turisti da tutto il mondo (gli eventi si svolgono rispettivamente a settembre e aprile/maggio).
In più, per i nostri amici buongustai, Leo consiglia la carbonnade (à la) flamande, un piatto tradizionale belga composto da uno spezzatino di manzo stufato e cipolla, bagnato con la birra e condito con timo e alloro… una delizia per il palato!
Concludiamo l’intervista tornando a focalizzarci su Roma: alla domanda “Leo, come descriveresti ciò che hai vissuto fino a ora?”, ci pensa un attimo e poi afferma: “sicuramente entusiasmante… ma la vera particolarità è che ognuno di noi può venire a Roma infinite volte nella sua vita, ma la città avrà sempre qualcosa di nuovo da insegnargli o da fargli scoprire!”.