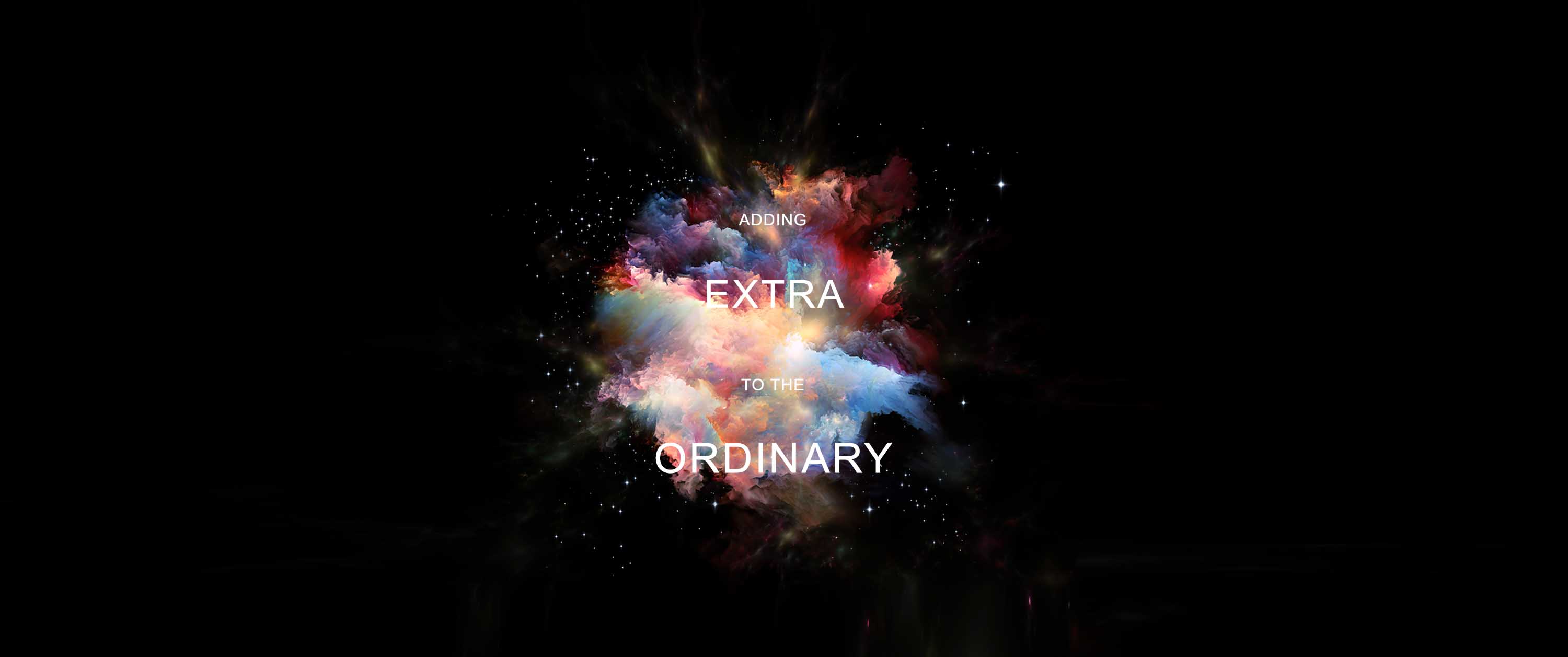Linguaggio inclusivo: perché una riscrittura è necessaria
Parlare è, ad oggi, un indubbio atto politico.
E ancor di più (re)insegnare a parlare e prendere coscienza della relatività linguistica non possono che essere atti dovuti, e necessari.
Cresciute in spazi pubblici eterogenei e a contatto coi mass media, sono maggiormente le nuove generazioni ad essere bombardate da un uso non controllato di parole, spesso incapaci di aderire ai nuovi orizzonti e alle nuove visioni in termini di diversità, e ancora veicolate a modelli offensivi e stigmatizzanti.
In una società iperconnessa, la sempre maggiore pervasività dei media e l’uso spropositato della lingua davanti ad ampi pubblici ha portato nella vita quotidiana di ognuno immagini cristallizzate di categorie concettuali, che vengono spettacolarizzate, adattate o sminuite a seconda delle esigenze, fino ad influenzare in maniera attiva l’opinione comune. La natura dinamica di questi immaginari antropologici che la lingua crea – e la grande quantità di canali sfruttati – ha trasfigurato la realtà con la creazione di concetti che preesistono alla concreta esperienza del singolo e che influenzano la percezione collettiva, confluendo in un repertorio di pregiudizi ed evocando una vasta gamma di associazioni mentali discriminatorie.
Nella creazione di categorie concettuali, il linguaggio assume così un ruolo centrale, alla luce dell’arbitrarietà linguistica e dell’arbitrario rapporto tra forma – la struttura, l’organizzazione interna – e sostanza – la materia – del significato: ogni lingua ritaglia in un modo che le è proprio (ed eventualmente, anzi spesso, diverso da quello delle altre lingue) un certo spazio di significato, e quindi attribuisce una data forma ad una data sostanza. La lingua sarebbe così in grado di categorizzare il pensiero, una massa amorfa e indistinta, ritagliando dei concetti e attribuendo ad essi una necessaria catalogazione. “I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo”, affermava infatti il filosofo Ludwig Wittgenstein, comprendendo come le categorie linguistiche e le categorie di pensiero siano interdipendenti e unite in un legame insolubile.
Una interessante ipotesi in merito, seppur estrema e non condivisa dall’intero panorama linguistico, è la cosiddetta ipotesi di Sapir-Whorf, conosciuta anche come ipotesi della relatività linguistica, secondo cui lo sviluppo cognitivo di ciascun essere umano è influenzato dalla lingua che parla. Secondo questo approccio, come estrema conseguenza, il modo di parlare determina il modo di pensare: per esempio, come affermato dal ricercatore Filipo Batisti, è del tutto verosimile che se una lingua che marca il genere grammaticale lo fa in maniera binaria tra femminile e maschile, i parlanti siano portati a pensare che non esista nulla al di fuori di questo binarismo; così come è verosimile che, a lungo andare, se si cancellasse il campo semantico della “compassione”, si cesserebbe di essere compassionevoli, o di comprendere la compassione stessa.
L’urgenza di discutere sul linguaggio inclusivo, dunque, è motivata dalla necessità di considerare quelle categorie potenzialmente escluse dalla lingua e dalle sue strutture linguistiche obbligatorie, verso modelli più accreditati e comprensivi.
È proprio la diversità, attualmente, la principale ricchezza in grado di avviare un processo di correzione, ripensamento e riscrittura che provenga “dall’interno” del sistema e che investa in primo luogo il piano linguistico, e poi, come naturale conseguenza, il piano culturale e sociale.
Parlare e scrivere in modo inclusivo, però, non è affatto semplice. Richiede impegno e sforzo, dato che implica, innanzi tutto, il superamento delle tradizionali convenzioni linguistiche, spesso assorbite inconsciamente nel corso del tempo. Perciò viene da chiedersi: “Ma ne vale davvero la pena?”
Premesso che utilizzare parole ed espressioni inclusive dipende dalla propria sensibilità individuale, è possibile affermare che sì, ne vale davvero la pena per diverse motivazioni.
In primo luogo, perché l’impiego di un linguaggio inclusivo può innescare profonde trasformazioni a carattere sociale e, di conseguenza, linguistico (considerato che l’evoluzione della lingua va di pari passo con quella della società stessa). Inoltre, utilizzare un linguaggio inclusivo è indice di empatia nei confronti delle persone e dimostra che si tiene conto delle loro scelte ed emozioni, il che consente di instaurare un legame di fiducia.
Sebbene di primo acchito si tenda ad associare il termine “linguaggio inclusivo” solo alle differenze di genere, in realtà esso comprende anche altri aspetti che riguardano la sfera sociale, quali l’orientamento sessuale, l’etnia, la religione, l’età o ancora la situazione economica. Perciò, come affermato da Alice Orrù, il linguaggio inclusivo è un linguaggio non sessista e antirazzista, che non rafforza stereotipi di genere e che non favorisce le discriminazioni generazionali.
Per rendere l’italiano inclusivo è possibile ricorrere a diverse soluzioni. Tra esse, cercare di non utilizzare determinate espressioni o parole che possono rimandare a discriminazioni, quali discriminazioni legate all’età (si vedano frasi come “sei così giovane, cosa vuoi capirne!”); avvalersi di parafrasi senza ricorrere all’uso di pronomi al fine di non dar luogo a discriminazioni di genere; o ancora, con riferimento a quest’ultimo caso, adottare una soluzione interessante e che tuttora suscita alcune polemiche: lo schwa.
Era il 2015 quando Luca Boschetto, appassionato di linguistica, sottolineò la necessità di attuare degli interventi in favore dell’inclusività nella lingua italiana, in modo da evitare, in particolare, le discriminazioni di genere. Luca Boschetto cercò quindi una soluzione linguistica efficace oltre a quelle esistenti (a suo avviso insufficienti per garantire l’inclusione linguistica), che potesse in primis apportare una risposta alla domanda: come è possibile rivolgersi alle persone che non si indentificano nel binarismo di genere?
Da quel momento, dunque, nacque la proposta dell’utilizzo dello schwa, sostenuta anche dalla sociolinguista e traduttrice Vera Gheno. Lo schwa (al singolare “ǝ”, e al plurale “з” in alfabeto fonetico internazionale) è la vocale centrale media per eccellenza che ha una pronuncia neutra, motivo per cui sembra prestarsi bene a indicare il genere indistinto, sia all’orale che allo scritto, senza ricorrere ad altri escamotage (come * o @) che invece, possono comportare delle difficoltà nella pronuncia.
Tuttavia, molte persone ritengono che lo schwa abbia un suono “anomalo” che non rientra nell’inventario fonematico dell’italiano standard – sebbene sia un suono presente in alcuni dialetti italiani–, mentre c’è chi, invece, non ne condivide proprio l’utilizzo, ritenendolo artificioso e innaturale. Perciò, questo fa sì che lo schwa incontri ancora numerosi ostacoli alla sua diffusione che, come sottolineato da Luca Boschetto, sono dettati principalmente dalla grande tradizione della lingua italiana e dalle opposizioni di chi si ostina a considerare la lingua intoccabile, immutabile e ancorata al passato.
In realtà, la lingua è in costante evoluzione e cambia quando chi parla ne sente l’esigenza, e questo è ciò che sta accadendo oggi. Infatti, vi sono delle esigenze socioculturali che richiedono soprattutto una maggiore consapevolezza in merito all’impiego delle parole, che sono estremamente potenti e che, se usate in modo improprio, rischiano di ferire e offendere le altre persone.
In quest’ottica, si rivela quindi essenziale sensibilizzare le persone al linguaggio inclusivo che, come si è visto, non riguarda solo l’uso dello schwa e non si limita esclusivamente alla questione di genere, ma rappresenta uno strumento che si propone di includere quante più persone possibili in un discorso, sia esso orale o scritto, senza alcun tipo di discriminazione.
Evelyn de Luca e Federica Zunino