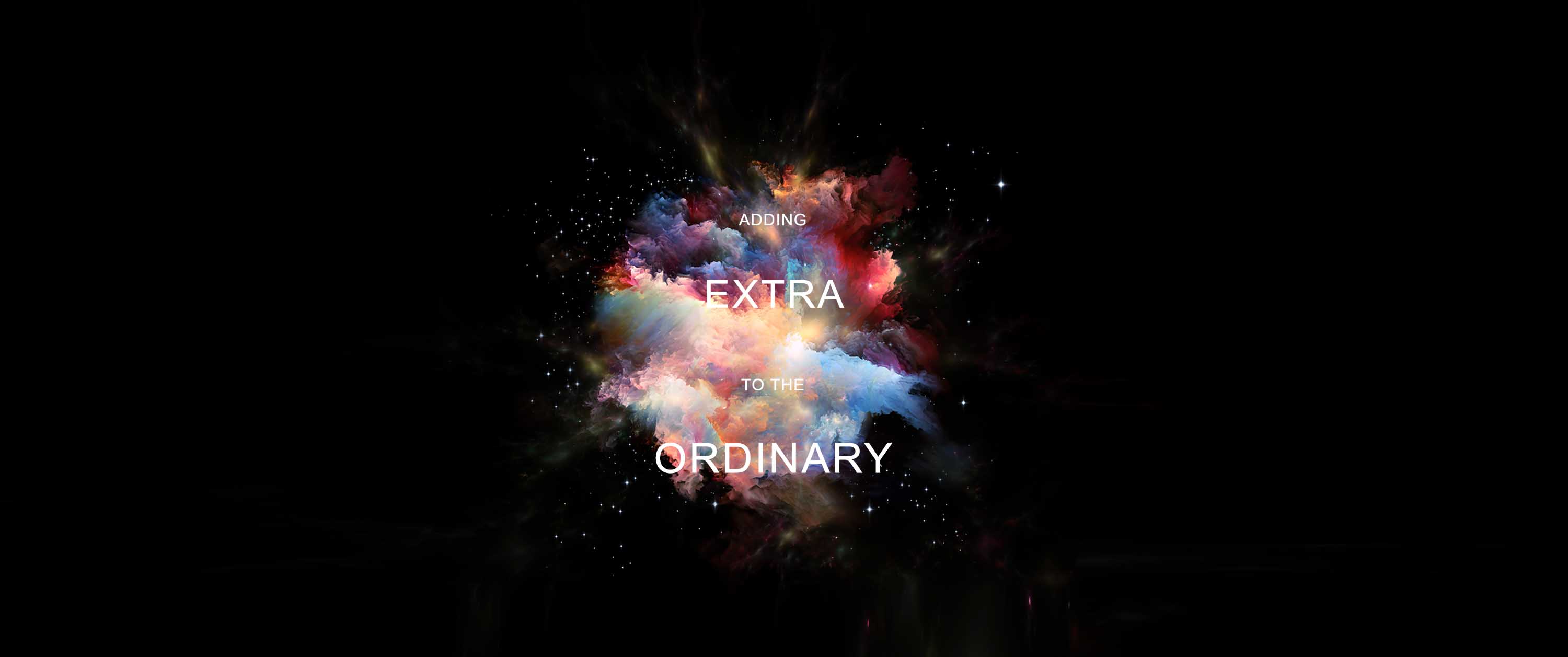Che musica, maestrə!
A pochi giorni dalla Giornata Internazionale della Donna, fa molto riflettere la dichiarazione di Beatrice Venezi che, sul palco del teatro Ariston, ha chiesto espressamente di essere definita “direttore” d’orchestra, e non “direttrice”. Se da una parte è lecito definirci come più ci aggrada, dall’altra è pur vero che rifiutare un appellativo declinato al femminile (vuoi per un’indigestione di politically correct, vuoi per la convinzione di fondo che il cambiamento linguistico non abbia niente a che vedere con il progresso sociale) veicola, volenti o nolenti, un messaggio ben chiaro. Nell’anno della prima vicepresidente statunitense donna, nera e asiatica, quel “Sono direttore d’orchestra, non direttrice” riaccende inevitabilmente la miccia del dibattito sull’utilità e la fattibilità di declinare al femminile i nomi di professioni tradizionalmente maschili.
Per noi appassionati di linguistica e appassionatissimi di morfologia nominale, sorgono spontanee alcune domande: l’italiano, che si avvale ancora del maschile plurale in funzione neutra, è una lingua intrinsecamente maschilista? L’inclusività linguistica può davvero sovvertire il patriarcato o non è che un magro premio di consolazione nel nome del politicamente corretto? Infine, se è un uomo a pronunciare la parola “direttrice” su uno dei palchi più seguiti d’Italia ed è proprio una donna a rifiutarla, è necessariamente un passo indietro nella scalata verso la parità di genere?
Ma andiamo per ordine.
“La lingua che si usa quotidianamente è il mezzo più pervasivo e meno individuato di trasmissione di una visione del mondo nella quale trova largo spazio il principio dell’inferiorità sociale della donna”. Si apre così il Rapporto della Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna intitolato Il sessismo nella lingua italiana. A prescindere dalla convinzione che la lingua sia al tempo stesso produttrice e prodotto della cultura patriarcale, è innegabile che la nostra bellissima lingua, insieme alle percezioni dei parlanti, contribuiscano a mantenere una visione stereotipata della donna e della rigida divisione tra ruoli di genere. Non a caso, come ricorda Paola Cortellesi in un suo ormai celebre monologo, “È impressionante vedere come nella nostra lingua alcuni termini che al maschile hanno il loro legittimo significato, se declinati al femminile assumono improvvisamente un altro senso, cambiano radicalmente, diventano un luogo comune […]: cortigiano/cortigiana, massaggiatore/massaggiatrice, uomo di strada/donna di strada…”.
Fortunatamente, un antidoto c’è, e si chiama scrittura inclusiva. L’idea di fondo è quella di innescare un mutamento linguistico per raggiungere una parità sostanziale nella società. È un modello che arriva dalla Francia, dove il dibattito sulla necessità di mettere a punto un sistema che possa includere ogni individuo è confluito nella pubblicazione di un vademecum da parte della casa editrice Hatier, che propone semplici accorgimenti come la declinazione al femminile dei nomi di professione (“sindaca”, “assessora”, ecc.) seguendo le regole della flessione nominale per coniare nuovi lessemi o tramite doppia flessione (es. “i ministri e le ministre”), l’utilizzo di parole e locuzioni neutre (“diritti umani” e non “diritti dell’uomo”) e l’uso del punto mediano [·], un segno di interpunzione che separa le desinenze del maschile e del femminile (“gli·le italiani·e”). In alternativa a quest’ultimo accorgimento, che in effetti funziona molto meglio in francese, in italiano si sta diffondendo l’utilizzo dell’asterisco o dello scevà [ə] al posto del morfema che esprime l’informazione relativa al genere della parola (“Buongiorno a tuttə!”).
È opportuno ricordare, tuttavia, che in ogni sistema-lingua che preveda una distinzione di genere tra parole, il legame che unisce significante e significato è totalmente arbitrario e dipende dall’associazione di un segno linguistico a un significato extralinguistico in modo convenzionale. Perciò “sentinella”, morfologicamente femminile, può essere impiegato per designare un uomo che svolga tale funzione. Anzi, nell’immaginario collettivo, la parola sentinella fa pensare a un “soldato armato addetto a turno e per un determinato spazio di tempo alla vigilanza […]”, non certo a una soldatessa.
Da ciò nascono, dunque, diverse scuole di pensiero: l’una basata sulla convinzione che sia ormai necessario ampliare l’inventario lessicale del sistema-lingua per includere tutt*; l’altra secondo cui l’enfasi sulla femminilizzazione dei nomi di mestieri e altri esempi di scrittura inclusiva abbiano perso di vista l’obiettivo principale: non tanto dividere, categorizzare e opporre tra loro i generi, quanto piuttosto trovare delle formule condivise per unire ed esprimere nel modo più inclusivo possibile ogni categoria, per esempio attraverso l’uso di formule neutre. Infine, una terza scuola di pensiero sottolinea come la polemica intorno all’introduzione di forme come “sindaca”, “avvocata” e perfino il più apparentemente cacofonico “assessora” sia intollerabile soltanto all’orecchio di chi non è ancora abituato all’idea di vedere una donna ricoprire ruoli tradizionalmente maschili. D’altronde, le ragioni per cui il termine “maestra” passa praticamente inosservato, mentre “fabbra”, la forma proposta dallo Zingarelli 2020, scatena ancora molte polemiche è da ricercarsi unicamente nella percezione dei parlanti poco avvezzi al mutamento sociale. Molti nomi di professioni sono declinati al maschile perché banalmente in passato non esistevano donne che svolgevano quel lavoro. Duecento anni fa, probabilmente, il termine “maestra” non sarebbe passato così inosservato come oggi. Lo spiega chiaramente la sociolinguista Vera Gheno: “La prevalenza di “minatore” su “minatrice” non ha una spiegazione interna al sistema linguistico, bensì al fatto che le minatrici sono poche nella storia di questa professione. Nella questione dei femminili professionali si uniscono una naturale resistenza al cambiamento e atteggiamenti culturali tradizionalisti, non necessariamente sempre maschilisti; tuttavia, alcuni parlano a questo proposito di patriarcato introiettato: siamo abituati a vedere la società attraverso una lente deformante”.
Una questione rimane però aperta: è lecito che una donna rifiuti una qualifica professionale declinata al femminile? Non è nostra intenzione entrare nel merito di tali scelte personali, né difendere una posizione piuttosto che un’altra (sarebbe tra l’altro necessario ascoltare le ragioni della diretta interessata). Rimane, tuttavia, il dubbio sul messaggio che traspare da questa vicenda: forse una professione, per essere considerata più prestigiosa, deve essere declinata al maschile? Che un traguardo abbia meno valore se a raggiungerlo è una donna?
Un dubbio che lascia ancora con l’amaro in bocca, soprattutto in un periodo storico in cui il gender pay gap è ancora un problema diffuso in tutto il mondo e considerando che l’Italia si posiziona al 76° posto su 153 nella classifica sulla parità di genere, dove il divario tra il tasso di occupazione delle donne rispetto agli uomini è del 18,9% e dove ci sono soltanto 4 donne tra i primi 100 manager più pagati d’Italia (e guadagnano quasi 5 volte meno dei colleghi maschi).
Vanessa Iudicone
Fonti:
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/IlSessismoNellaLinguaItaliana.pdf, consultato in data 09/03/2021.
https://www.google.com/search?q=sentinella&oq=sentinella+&aqs=chrome..69i57j0l2j0i131i433j0j0i131i433j0j46j0l2.1694j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8, consultato in data 09/03/2021.
https://www.youtube.com/watch?v=4WjhLSkXqTk, consultato in data 09/03/2021.
https://newsicilia.it/italia/cultura/beatrice-venezi-direttore-o-direttrice-dorchestra-i-limiti-del-linguaggio/651474, consultato in data 09/03/2021.
https://www.donne.it/gender-gap/?gclid=Cj0KCQiA1pyCBhCtARIsAHaY_5eWbrJLAQtwLpKHG5jts5m5zWGH1uYXTkltj0R4W3BWH-6QS_b6BUUaAjaeEALw_wcB, consultato in data 09/03/2021.