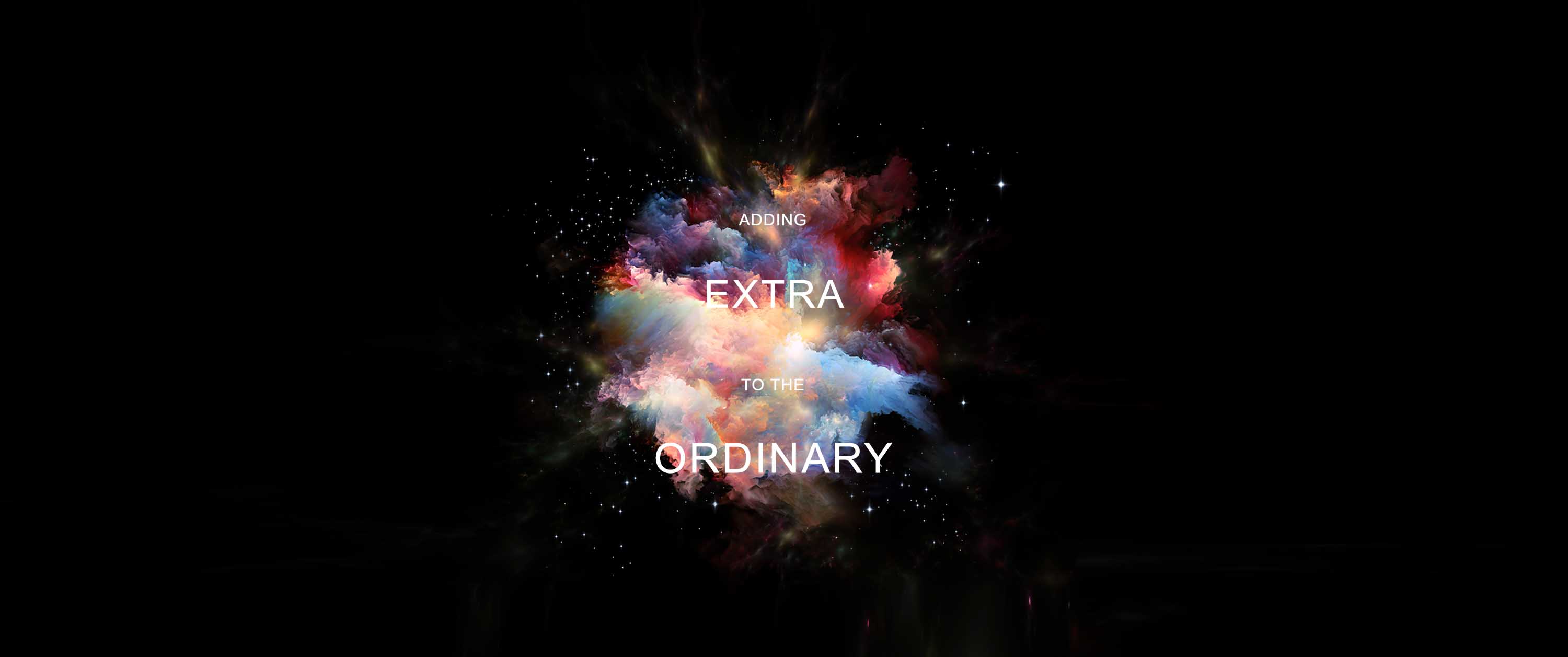La caduta del Muro di Berlino è un vero punto di svolta della storia europea e mondiale. Fu evento inaspettato, non previsto dalle élites europee, ma ripensato in prospettiva storica possiamo oggi dire che il suo verificarsi derivò da cause di medio e lungo periodo. Non poco pesò l’avvento di Michail Gorbačëv alla segreteria del Pcus. Egli tentò di riformare l’irriformabile con le sue idee di Perestroika e Glasnost. Oggi sappiamo dagli archivi quanto brancolasse nel buio, assieme al suo partito e all’intero movimento comunista internazionale. Nonostante ciò, la sua figura conferma il ruolo che spesso giocano le personalità nella storia, e ce ne furono di numerose in quel decennio che precedette il 1989: da Reagan alla Thatcher, da Giovanni Paolo II a Craxi, da Mitterand a Lech Walesa e molti altri coraggiosi dissidenti anticomunisti. Tutti loro furono, ciascuno a suo modo, fattori di dinamismo e accelerazione di processi già in corso.
Dalla periferia dell’impero sovietico s’innescò sin dalla primavera di quell’anno un processo di sgretolamento che culminò a Berlino il 9 novembre di trent’anni fa. La Cortina di ferro subì infatti la prima breccia il 2 maggio 1989 in Ungheria, a Hegyeshalom, 170 chilometri da Budapest e 80 da Vienna. 345 chilometri di reticolati, fortificazioni, bunker e muri lungo tutto la frontiera con l’Austria. Accadde proprio là dove oggi si ricostruiscono muri e fili spinati, a testimoniare a trent’anni di distanza che quella stagione ha mancato nei decenni seguenti una serie di passaggi cruciali. Uno tra questi è stato il non affiancare all’allargamento della comunità europea, processo sicuramente favorito dai fatti del 1989, la costruzione di una politica estera e di difesa comune. Oggi assistiamo pertanto ad un’unione europea che regge ad Est, e non solo, fintantoché reca vantaggi sul piano del rilancio delle singole economie nazionali, e solo se si accompagna a politiche autonome, mosse da interessi nazionali e non comunitari, sul piano della sicurezza interna ed esterna di fronte ai flussi migratori di massa.
L’89 ha segnato la fine del sistema bipolare, che diventò definitiva nel 1991 con il crollo dell’Urss. Ad un periodo di isolamento degli Stati Uniti e all’illusione di un nuovo ordine mondiale unipolare è seguito l’ultimo ventennio, inaugurato dall’11 settembre 2001, in cui la globalizzazione ha dimostrato di non essere governabile nel nome esclusivo del mercato e della tecnologia. L’89 fu anche lo sbocco di un decennio ottimista, gli anni Ottanta, e l’avvio di un altro ancor più ottimista, quasi utopistico. Gli anni Novanta cullarono l’utopia della liberaldemocratizzazione del globo. Ciò detto, in quel decennio si ebbe un’indubbia crescita economica europea tanto ad Est quanto ad Ovest, e più ad Est che ad Ovest. Una delle poche eccezioni fu proprio l’Italia, il cui sistema politico implose, un po’ per effettiva incapacità di autoriformarsi, un po’ per la convinzione delle nostre élites nazionali che solo un vincolo esterno potesse salvarci. Di qui, inizialmente, una maggiore infatuazione europeista nel nostro Paese rispetto ad altri, salvo poi vederlo tramutare negli ultimi sette-otto anni in uno di quelli con più marcati fenomeni di rigetto politico del processo di integrazione. L’Italia come uno dei laboratori del nuovo populismo euroscettico e sovranista. Più in generale, dopo il 2001 e la grande recessione del 2007-2008 è subentrato un periodo di pessimismo e depressione che è figlio tanto dell’insicurezza rispetto al terrorismo internazionale e alle grandi migrazioni quanto dell’impoverimento relativo delle classi medie per una globalizzazione divenuta sinonimo di delocalizzazione e concorrenza sleale.
Ottimismo e pessimismo anzitutto europei, quindi occidentali. Nel trentennio successivo al 1989 il mondo asiatico, ad esempio, ha invece conosciuto complessivamente una fase di espansione, tanto da far dire ad alcuni che siamo entrati nel “secolo cinese”. Quel che è certo è che siamo in una fase avanzata ma non conclusa di ristrutturazione multipolare dell’ordine internazionale e gli scontri di civiltà di cui parlava a metà anni Novanta Samuel P. Huntington sono anche conflitti crescenti dentro ciascuna di esse. Penso tanto alla civiltà europea, per via della massiccia immigrazione di popolazione musulmana, quanto alla stessa civiltà islamica, attraversata da una lunga fase di violentissime guerre civili di religione, assimilabili a quelle vissute dall’Europa tra Cinque e Seicento.
Per il futuro dell’Europa occidentale siamo ad un bivio decisivo. Ripensando a trent’anni fa, a quella stagione di libertà e liberazione, le élite politiche europee devono oggi partire da una realistica constatazione dell’attuale situazione di paralisi, agire con inedito coraggio e apportare importanti correttivi all’Unione europea. Ad oggi pare però prevalere una logica del “si salvi chi può”. L’entusiasmo popolare del 1989 sbiadisce così all’orizzonte. Ma la storia non si ferma e nulla è già scritto.
Danilo Breschi
Professore di Storia delle dottrine politiche
Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT