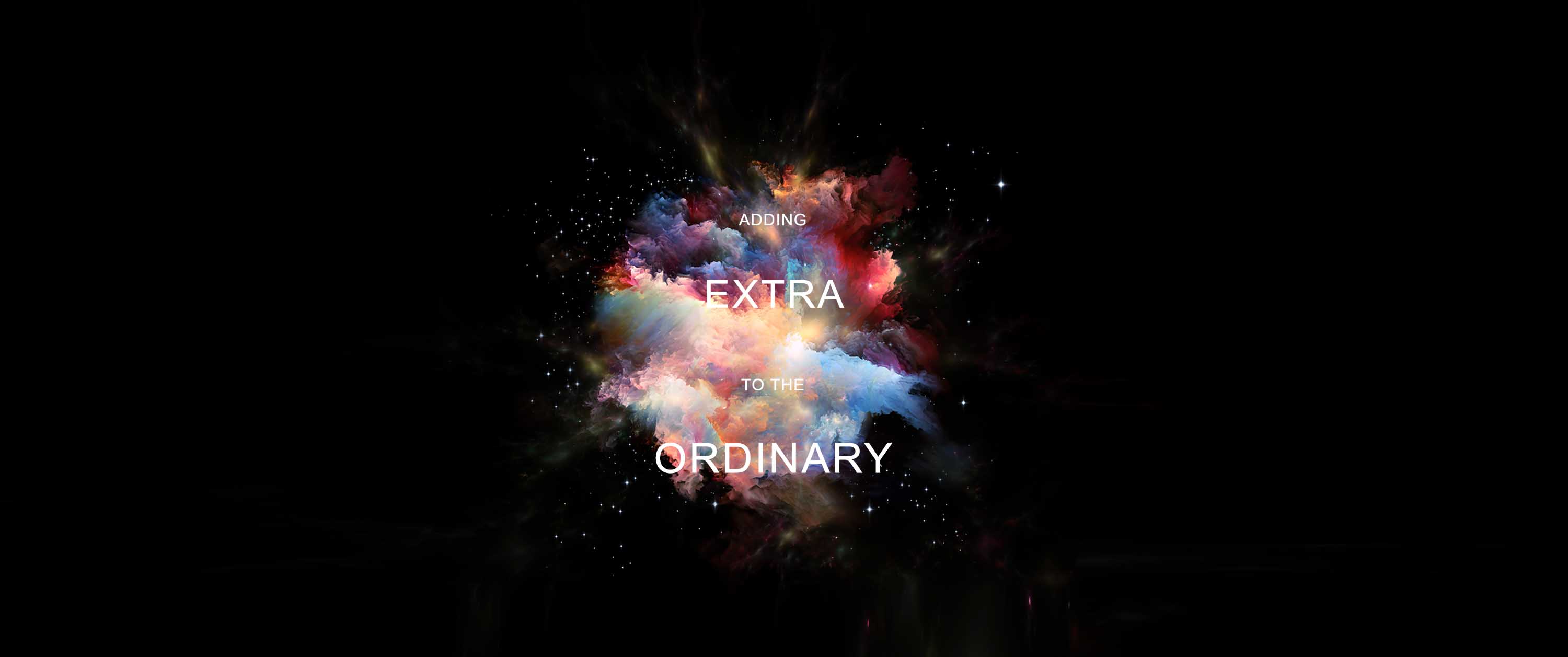Linguaggio inclusivo e migrazioni: come e perché parlarne?
È un dato di fatto: negli ultimi anni la configurazione della nostra società si è incredibilmente trasformata.
Oggi, infatti, viviamo in una società in cui siamo intimamente connessi reciprocamente e in cui dipendiamo praticamente l’uno dall’altro, e questo è accaduto perlopiù dell’aumento dei fenomeni migratori, che hanno pressoché eliminato i confini tra i Paesi.
Il fenomeno migratorio, infatti, non solo è un importante fenomeno sociale, culturale ed economico, ma si tratta anche di un evento diventato sempre più assiduo. Esso ha pressoché eliminato barriere tra i Paesi e soprattutto ha messo più lingue e culture a confronto in posizione asimmetrica.
Perché asimmetrica? Perché la posizione del paese di accoglienza è più ‘forte’, e ciò costringe l’immigrato a mettersi in una situazione svantaggiata che spesso si rivela uno scontro, alla base del quale vi è, essenzialmente e quasi sempre, un’incomprensione, che parte dal rifiuto, più o meno consapevole, del punto di vista dell’altro, e che sfocia, purtroppo, in episodi di razzismo.
Tuttavia, dietro l’etichetta di ‘immigrati’ si cela un pubblico molto eterogeneo per bisogni, età, livelli di scolarizzazione, stili d’apprendimento, contesti ed esigenze d’inserimento sociale, o ancora, situazione familiare.
Ecco perché, quando si parla di migranti, è necessario tenere in considerazione gli aspetti appena esposti, nonché la sensibilità di ciascun individuo, favorendo l’impiego di una comunicazione pubblica inclusiva, che utilizzi modelli, linguaggi e strumenti che consentano di raggiungere una popolazione che, in numerosi contesti sociali come il nostro e come quello attuale, appare sempre più eterogenea (a fronte della rilevanza del fenomeno migratorio come sopra esposto) e portatrice di bisogni che cambiano nel tempo e nello spazio.
In quest’ottica, uno degli strumenti principali e più potenti a nostra disposizione è rappresentato dal linguaggio inclusivo.
Quest’ultimo, infatti, è un linguaggio antirazzista, rispettoso delle differenze e delle sensibilità individuali, che prende come punto di riferimento i bisogni e le necessità di ogni persona e, con particolare riferimento a questo caso, che garantisce l’inclusione e l’integrazione dei migranti, obiettivo fondamentale nel lavoro messo in atto in molti contesti locali da cittadini e società civile.
Quanto può il linguaggio inclusivo influenzare la percezione di un fenomeno, e l’opinione pubblica ad esso connessi? Basti pensare alla cosiddetta G2, una categoria di “seconde generazioni” discussa sia a livello sociale sia linguistico; Cresciuti in famiglie immigrate ma parallelamente educati nel Paese di nascita, socializzati in spazi pubblici compositi a contatto coi mass media in un contesto iperconnesso, culturalmente e socialmente più inseriti nelle istituzioni mainstream, pur scontrandosi sempre con discriminazione e pregiudizio. Ma sono loro, attualmente, la principale ricchezza per una riscrittura che proviene “dall’interno” del sistema e che investa il piano linguistico, culturale e sociale, per una percezione più giusta del fenomeno migratorio come dato strutturale delle società postmoderne e postcoloniali.
L’interesse scientifico e l’apprezzamento verso questa nuova dimensione sono dovuti all’attualità dei problemi sociali e alla peculiarità del panorama italiano ancora in fieri, carente in termini di riconoscimento pubblico e di istituzionalizzazione rispetto a Paesi quali la Gran Bretagna, la Francia o la Germania e con una composizione più eterogenea, priva di una cultura predominante rispetto ad altre realtà sociali. La stessa definizione di «seconda generazione» infatti racchiude ragazze e ragazzi figli degli immigrati, nati in Italia oppure arrivati nel Paese nei primi anni di vita o anche in fase adolescenziale; rappresenta una categoria che raccoglie dunque le casistiche più disparate con storie e background culturali profondamenti diversi tra loro.
La presenza sempre più numerosa di questa componente eterogenea rende necessaria una riflessione sull’esito – a distanza di decenni – dell’immigrazione sul piano sociale e su come essa sia descritta dal linguaggio giornalistico; su come siano mutati i rapporti tra due o più culture che si scontrano e si incontrano e sulle possibili distorsioni operate dalle scelte linguistiche sbagliate.
Con la costruzione della paura e lo stigma dell’infamia mediatica, si tende a costruire per autodifesa un nemico esterno, che crea una maggiore compattezza interna; come affermato da Umberto Eco in “Costruire il nemico e altri scritti occasionali” un nemico è necessario per costruire la propria identità e per creare un ostacolo rispetto al quale misurare il proprio sistema valoriale e rispetto cui dimostrarsi vincenti. Il nemico per eccellenza – quello più adatto a canalizzare l’odio e la paura verso l’alterità – è colui che si fa portatore di tradizioni diverse, di una lingua diversa, di un colore diverso, e che sembra minare l’integrità sociale. In questo senso i media non solo sono interpreti dell’opinione pubblica ma, quel che è più importante, fanno opinione pubblica, soprattutto nella fase storica in cui le agenzie di socializzazione tradizionali (la scuola, la Chiesa, i partiti) sembrano non possedere strumenti adeguati a intervenire su un pubblico di massa.
Dalla necessità di monitorare gli immaginari che sono veicolati dai mass media nasce l’iniziativa della Carta di Roma; fondamentale è evitare tutti i rigurgiti di razzismo e xenofobia che – spesso involontariamente – vengono tramandati attraverso i principali canali di comunicazione. La Carta di Roma nasce per scelta dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) come conseguenza della strage di Erba nel gennaio 2007, spettacolarizzata e ampiamente dibattuta con la diffusione di una rappresentazione alterata dei personaggi coinvolti e una loro stigmatizzazione. La Carta di Roma è infatti un protocollo deontologico redatto congiuntamente dal sindacato dei giornalisti e dall’Ordine dei giornalisti nel 2008, per ribadire la responsabilità morale e civile della figura del giornalista; una giusta comunicazione e una giusta terminologia relativamente al tema dell’immigrazione e dell’asilo diventa così un obbligo deontologico.
Nei principi enunciati nella Carta, c’è la necessità di evitare comportamenti superficiali e non corretti che possano suscitare allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie associazioni di notizie compromettendo le categorie sociali coinvolte e la percezione di esse nell’opinione pubblica, con informazioni imprecise o distorte. Il corretto uso terminologico, infatti, non lede in alcun modo la libertà di informazione; al contrario, veicola una informazione corretta, neutrale, con l’uso di termini giuridicamente appropriati al fine di restituire al lettore la massima aderenza alla realtà dei fatti, salvaguardando tutte le categorie sociali e decostruendo un nemico solo immaginato.
Federica Zunino e Evelyn de Luca