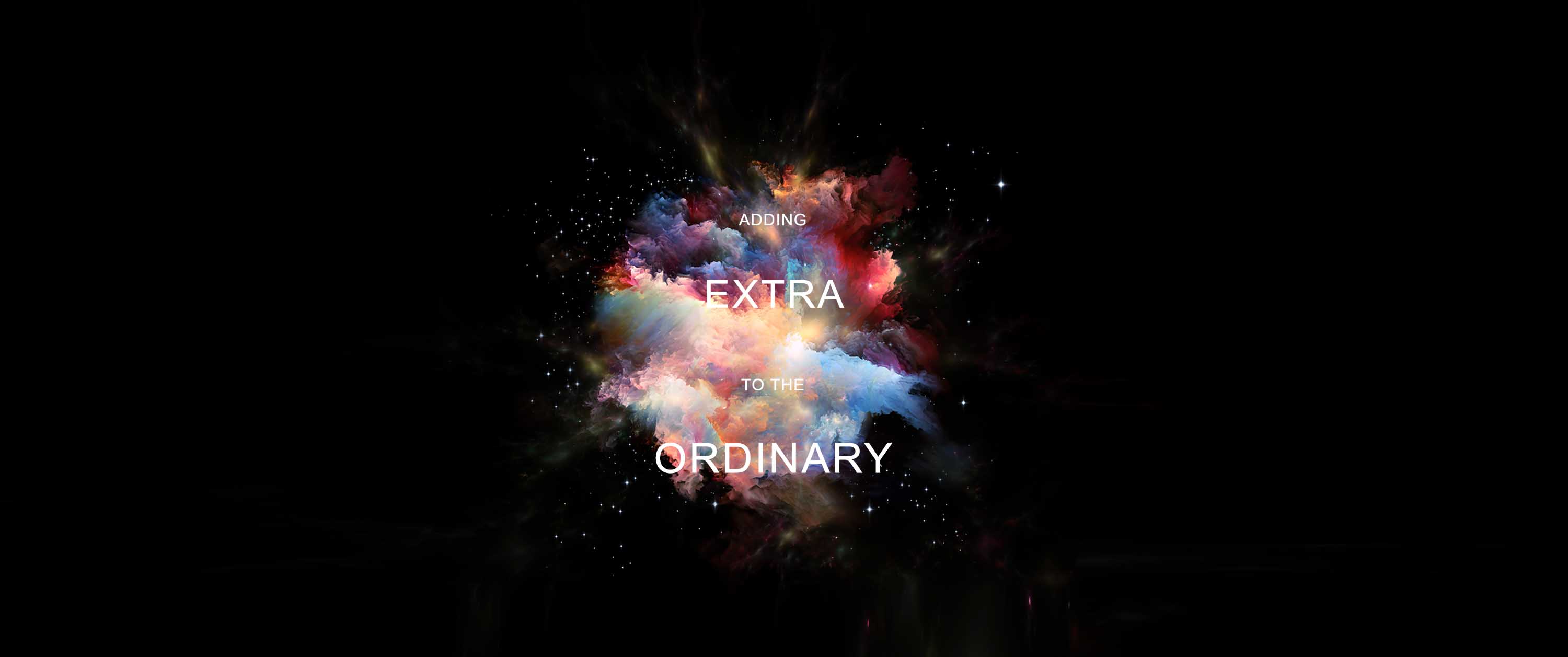Il nostro quartiere
Il novecento sarà a lungo considerato il secolo dei grandi traumi, non solo politici e sociali, bensì pure antropologici. La crisi che ne è derivata è divenuta nel corso dei decenni cifra insostituibile di tale periodo storico, occupando della realtà l’anima e il corpo. Tra i concetti più icastici per raffigurare la portata del fenomeno, la filosofia di tipo esistenzialista ha evocato la nozione di Bodenlosigkeit, vale a dire il verificarsi di una situazione in cui l’uomo è sottratto dal proprio spazio di origine per essere gettato in un altrove ostile a lasciarsi abitare. L’uomo in questo scenario non è più a casa, egli vaga tra città sfigurate e luoghi insoliti.
Senz’altro gran parte delle letterature e dell’arte tutta hanno fatto del derivato sentimento di nostalgia il loro fuoco sacro, nel tentativo di soggiornare nell’inabitabile. Pagine di scritti elucubrati in Europa come nel restante mondo sviscerano questo amaro spaesamento in cui il fantasma poetico è di volta in volta l’altro, l’indecidibile, ma anche il perturbante e la negazione. La Storia, matrigna, è parte in causa con le ragioni profonde dei nostri mali: essa rappresenta il pericolo mortale per ogni epoca, il suo grembo è la scaturigine di una filiazione letale per quella precedente. Di questa sorte infausta hanno sofferto in particolar modo le propaggini delle civiltà antiche, che da un lato all’altro dell’orbe terracqueo, poco hanno potuto difronte l’implacabile razionalizzazione dello spazio mondano promossa dalla modernità. E non alludo alle grandi istituzioni religiose che tutt’ora, malgrado il dirompente nichilismo, continuano a parlare alle grandi masse; mi riferisco invece a quelle che Pasolini definiva “culture particolari”, sottosuolo di nozioni popolari distinto dal patrimonio e dall’orientamento culturale superiore ed egemonico.
Cantore eccelso di miti silenziosi è stato lo scrittore egiziano Nagib Mahfuz, tra le voci più alte e riconosciute della letteratura in lingua araba, non solo in ragione del plauso internazionale a seguito della ricezione del Nobel; la sua opera è andata consacrandosi per il raffinato mosaico di temi e storie che egli ha tessuto dentro il grande museo della letteratura arabofona. Pregevole prosatore e intellettuale superbo, Mahfuz è stato testimone dei grandi sconvolgimenti avvenuti in terra egiziana e più latamente nel mondo arabo-islamico. Il confronto con l’Europa liberale e la sua macchina tecno-burocratica, ora considerata miracolo ora considerata demone distruttore, è fantomaticamente presente in quasi tutta la sua opera.
Ed è in uno dei suoi romanzi più tardi che Mahfuz metterà magistralmente a tema questa ambivalenza storica, espressa in una tensione tra sacro e profano. Il titolo dell’opera in questione è Ḥikāyat ḥāritna pubblicato nel 1975 e tradotto a distanza di un decennio da Feltrinelli col titolo Il nostro quartiere. Il romanzo è un antologia di 78 piccoli racconti, in cui le uniche costanti sono il quartiere stesso e l’io narrante, compresi in rapporto e secondo una coappartenenza reciproca. Tra essi un’epopea di vite e gesta quotidiane incarnate da ribaldi, probi, marabaldi e timorati di Dio. Sullo sfondo la presenza incombente di una modernità strisciante e subdola, serpente veterotestamentario. Siamo negli anni dell’occupazione inglese e dell’urlo libertario evocato da indipendentisti e illuministi cairoti, eventi che tuttavia paiono non ripercuotersi, se non fievolmente, sulla realtà del quotidiano. A protezione di istanze sovvertitrici, si erge nel cuore del quartiere un venerabile monastero custodito da una confraternita sufi, dedita ad una mistica clausura aperta solo verso il cielo. I sogni e le impressioni del giovane io narrante aleggiano all’ombra di questa antica filosofia orientale, retta e dura, la quale apre e interdice spiragli di comprensione. Così come agisce, in modalità contrapposta, l’efficienza del moderno, affascinate e prevaricatrice. Verso la fine del romanzo, un nuovo piano regolatore urbano prevede che il monastero debba essere abbattuto. La decisione alfine rimane sospesa, senza che nessuno decida sul da farsi, ma il semplice fatto di aver avanzato una simile proposta è segno che la sacralità del monastero è stata profanata. Le ripercussioni desteranno gravi sospiri nell’animo di colui che narra, manicheisticamente dibattuto tra sacro e profano, fino a sviluppare un sentimento nostalgico per un antico equilibrio sempre più inficiato da forze estranee ed estranianti. Egli si rende conto di come lo stesso spazio sia soggetto ad interpretazioni differenti, scaturenti dal modo peculiare in cui la significatività del mondo è interpretata, sovente l’una escludente l’altra.
La descrizione che Mahfuz offre del Cairo e dell’Egitto del suo tempo risulta giocoforza animata da una certa interna contraddizione: da un lato al lascito degli europei va l’indubbio merito di essere una cultura basata su leggi pragmatiche, dall’altro permangono le riserve dettate dalla fede, che fanno sì che la fascinazione di un intera generazioni di scrittori per il progresso sia sempre comunque attenuata dalla consapevolezza che esso non abbia l’ultima parola, non sia la sola casa rimasta.
Livio D’Alessio